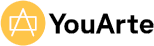Nascere nell’Asmara del 1942, in piena guerra, non può che essere l’incipit di una grande storia. E quella di Massimo Antonelli è davvero una di quelle degne di essere raccontate. Figlio di un funzionario di banca e una casalinga, da bambino Massimo non ha il tempo di affezionarsi al una delle più belle città d’Africa, che si trasferisce ancora piccolissimo in Italia, nei dintorni di Campobasso. È nella casa in campagna del nonno, un posto dove la sola compagnia è quella di se stessi, che trova la cassetta di colori lasciata lì dallo zio Cesare, anche lui un pittore, e si innamora a prima vista di quelle tinte a olio che sembrano aver resistito al tempo.

I suoi primi approcci con la pittura nascono nel tentativo di imitare le opere dello zio, bozzetti a tema paesaggistico che riprendono la campagna e la solitudine della natura. Ancora adolescente incontra Gilda Panziotti, sua mentore, da cui apprende l’arte del disegno della figura umana.
Eppure, nonostante gli incoraggiamenti, Massimo sente di non aver ancora trovato la sua strada come pittore, di non avere uno stile o un tema che lo rappresenti. Per questo motivo abbandona le tele per dedicarsi alla macchina da presa sotto la guida di nomi come Rossellini e Maselli.
Leggi anche: L’ARTE DELLA SOTTRAZIONE DI BRUNO MELAPPIONI: LIBERARSI DEL SUPERFLUO PER ARRIVARE ALLE EMOZIONI
È durante i suoi anni al Centro Sperimentale di Cinematografia che si avvicina alla causa degli emarginati, durante le contestazioni del ’68, vissute tra il montaggio di documentari e la visita mostre d’avanguardia. Ecco che i suoi grandi amori finalmente si uniscono: colore, emarginazione, desiderio di lotta. Massimo trova la sua visione e decide di dare una seconda possibilità alla pittura dipingendo quello che egli stesso definisce disgregazione urbana.
I grattacieli come grattugie: alienazione e solitudine, ma non solo
Il tema della metropoli è presente un po’ dappertutto nelle sue opere: palazzi deserti, senza uomini e quindi per estensione senza umanità, che vengono riproposti con una moltitudine di mezzi diversi: dipinti, installazioni, composizioni. Un unico oggetto, trovato quasi per caso, è l’elemento ricorrente delle composizioni, al punto da essere diventato simbolo stesso della sua arte: la grattugia.
Ma perché proprio una grattugia? Perché è il mezzo perfetto per raccontare l’angoscia di vivere che logora la condizione umana. Lo stesso autore ha affermato in una delle sue interviste:
Un giorno vorrò aprire le grattugie con un apriscatole, per trovare, in maniera minimalista, qualcosa che mi aiuti a capire ancora di più la società di oggi.
 In verità, una volta compresa la chiave di lettura, l’accostamento è semplice. La grattugia è capace di raschiare via e logorare i tessuti, compresa la carne umana. Inoltre, a guardarla da lontano, assomiglia a un grattacielo. Le città moderne, con i loro grattacieli, le loro dimensioni schiaccianti a confronto dell’uomo, diventano mezzo di alienazione per gli stessi personaggi che le abitano.
In verità, una volta compresa la chiave di lettura, l’accostamento è semplice. La grattugia è capace di raschiare via e logorare i tessuti, compresa la carne umana. Inoltre, a guardarla da lontano, assomiglia a un grattacielo. Le città moderne, con i loro grattacieli, le loro dimensioni schiaccianti a confronto dell’uomo, diventano mezzo di alienazione per gli stessi personaggi che le abitano.
Ecco la visione: i grattacieli che compongono le città sono come milioni di grattugie che graffiano l’umanità, i loro buchi sono angosce, paranoie e alienazione. Antonelli, che è cresciuto in un luogo molto più a misura d’uomo, ha visto la potenza schiacciante della metropoli e la rappresenta così.
Se chiedi aiuto da una finestra di un grattacielo, non ti sente nessuno – continua l’autore.
Tuttavia, in questo mare di angoscia e alienazione che permea le sue opere, un elemento sembra voler rompere gli schemi: il colore. Tutte le sue grattugie sono smaltate e ricche di riflessi e sfumature.
Un modo, forse, per ricordarsi di quel suo primo amore, un modo, utilizzando le parole di Massimo Lupoli, per colorare la tristezza.
Leggi anche: RIBALTARE IL CONCETTO DI OPERA D’ARTE: LA VISIONE DI MASSIMO LUPOLI
È in quest’ottica che un tema all’apparenza straziante assume una connotazione del tutto differente: una rivolta in un certo senso, forse un ricordo inconscio di quella perla che è Asmara, la città che gli ha dato i natali. Oppure un’eco di un’infanzia vissuta in pace con se stessi. Forse un barlume di speranza. Del resto colorare la tristezza non è un’impresa che può lasciare indifferenti.